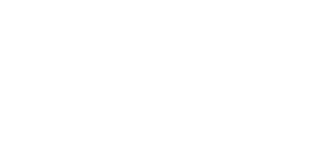Un nuovo Topic, apparso di recente su Neuropsychopharmacology, di Amit Etkin, tra i massimi ricercatori ed esperti nel campo del Disturbo da Stress Post-Traumatico, precisa le nuove metodologie e tecniche che potranno consentire di ancorare la definizione clinica di tale disturbo a misure maggiormente oggettive e quantificabili, dal momento che attualmente la sua diagnosi si affida a caratteristiche o descrizioni fenotipiche e sintomatologiche ancora troppo imprecise.
Caratteristiche che nella maggior parte dei casi non si ravvedono in modo uniforme ed omogeneo nell’intera popolazione clinica di pazienti affetti da questa condizione.
Gli individui che presentano un Disturbo da Stress Post Traumatico generalmente manifestano un ventaglio così vasto di sintomi psicologici e alterazioni neurobiologiche da rendere problematica una definizione univoca e oggettiva della patologia.
Per esempio, nell’ultima revisione dei suoi criteri diagnostici-nosografici avvenuta nel passaggio da DSM IV-TR a DSM 5, solo nel 50% dei casi si è riscontrata una reale sovrapposizione sintomatologica tra gli individui affetti da PTSD all’interno della popolazione clinica presa come riferimento (Stein, McLaughlin et al., 2014).
Date queste premesse, a parere di Etkin, appare necessario investigare nel modo più oggettivo e quantificabile possibile quelle che sono le componenti biologiche e cliniche dei vari sottotipi di Disturbo da Stress Post-Traumatico tramite compiti cognitivi e comportamentali, con il fine di superare quelle problematicità che si riscontano durante il procedimento diagnostico, ancorando le manifestazione fenotipiche dei pazienti a misure più oggettive e affidabili (Etkin, Maron-Katz, Fonzo et al., 2019).
Partendo dalla neuropsicologia, tra i vari domini cognitivi, già J. Scott dell’Università della Pennsylvania in una sua meta-analisi del 2015, aveva sottolineato come in particolare la memoria verbale risultasse in media estremamente deficitaria negli individui con diagnosi di PTSD e come il funzionamento neuropsicologico di questi pazienti nell’area dell’attenzione, della memoria e del processamento cognitivo fosse da considerarsi al momento dell’effettiva presa in carico e valutazione clinica di questi pazienti e come questi dati potessero avere delle importantissime ripercussioni e implicazioni per il successivo trattamento psicologico o terapeutico di questa tipologia di pazienti (Scott, Matt, Wrocklage et al., 2015).
In linea con questo pensiero, in un loro recente studio, Etkin e colleghi (2019) del dipartimento di Psichiatria e Scienze Comportamentali dell’Università di Stanford, del Wu Tsai Neurosciences Institute e del Veterans Affairs Palo Alto Healthcare System, hanno esaminato in una dimensione normativa i punteggi ottenuti dagli individui con diagnosi di PTSD in un compito di memoria verbale e i loro rispettivi dati ottenuti tramite risonanza magnetica funzionale ottenendo, sulla base delle loro prestazioni – situate all’interno o al di fuori della curva di normalità – due sottogruppi con la medesima diagnosi, ma con differenti capacità mnestiche.
Nel dettaglio, combinando i punteggi ottenuti ad un compito di apprendimento di una lista di parole con le evidenze di neuroimaging, i ricercatori hanno mostrato come il sottogruppo al di fuori della curva di normalità, ovvero che presentava una performance peggiore nel compito di apprendimento, presentasse un’alterazione a livello del circuito attentivo ventrale (VAN; Ventral Attentional Network), rispetto al sottogruppo di individui con la medesima diagnosi, ma posizionatisi all’interno della curva di normalità e ad un gruppo di controllo.
In aggiunta, in modo sorprendente, gli autori hanno trovato come la combinazione di questi dati non fosse associata a differenze nella sintomatologia o a comorbilità, ma fossero in grado di predire una scarsa o addirittura un’assenza di risposta di uno dei due sottogruppi di pazienti a interventi di esposizione prolungata, inseriti nel trattamento evidence-based per il PTSD (Etkin, Maron-Katz, Fonzo et al., 2019).
Infatti, il sottogruppo di pazienti i cui punteggi si erano posizionati al di fuori della curva di normalità e che presentavano una ridotta attività del circuito VAN, esibivano una maggiore resistenza durante le sessioni di esposizione prolungata, a differenza del gruppo di controllo e del sottogruppo PTSD con performance di memoria verbale nella norma.
Al di là della scoperta dell’alterazione nel funzionamento del circuito neurale VAN, tali evidenze prodotte da Etkin e colleghi (2019) hanno dimostrato la rilevanza clinica di dati neuropsicologici nell’ambito del trattamento psicoterapeutico, in particolare nella scelta e nel successivo adattamento dell’intervento da intraprendere a seconda delle caratteristiche neuropsicologiche del paziente e non più rispetto alla sua diagnosi.
Questo si potrebbe definire un modello multidimensionale di concezione del disturbo psicologico, che trascende la classica e tradizionale nosografia basata quasi esclusivamente sulla descrizione sintomatologica e fenotipica della popolazione clinica di riferimento. Proprio questo modello sta acquisendo progressivamente maggior rilevanza in quanto, rispetto al precedente, fonda la descrizione clinica di un disturbo su biomarkers oggettivi, che possono rivelarsi significativi non solo durante l’iter per il raggiungimento di una diagnosi, ma anche per il conseguente intervento terapeutico.
A parere di Etkin alcuni strumenti come l’elettroencefalografia, più economica e di più immediato utilizzo rispetto alla risonanza magnetica funzionale, o device di machine learning per una raccolta e analisi più robuste e strutturate di dati cerebrali, potrebbero essere ben presto richiesti per contribuire alla formulazione di una diagnosi in ambito psichiatrico assieme ai consueti strumenti diagnostici.
Il contributo dei biomarker alla diagnosi e al trattamento non sarà più un’eventualità, ma rapidamente verrà richiesta come conditio sine qua non all’interno del procedimento diagnostico.
Fonte: Stateofmind.it