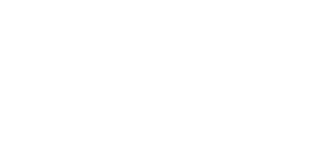Sono sempre più numerosi gli psicologi che scelgono di aprire profili pubblici su Instagram e non sorprende visto che lo stesso New York Times ha descritto i Millennials come la Therapy Generation. Ma chi sono davvero i loro follower? Chi è, insomma, il pubblico che segue i consigli che questi terapisti scrivono nei loro post? Soprattutto donne, tra i 25 e i 40 anni, ma non solo ovviamente. E infatti gli argomenti affrontati sono i più diversi: dalla salute mentale all’ansia, passando per insicurezza, crisi di coppia, rapporti genitori/figli. «Tra gli aspetti positivi dell’uso dei social c’è senz’altro quello di riuscire a parlare con chiarezza di un mestiere sul quale c’è ancora molta confusione», racconta la dottoressa Arianna Capulli (@ariannacapulli, 5mila follower), psicologa e specializzanda psicoterapeuta a indirizzo cognitivo-comportamentale e intervento psicosociale.
«Per esempio, sono in tanti a non sapere quale sia di preciso la differenza tra psicologo e psicoterapeuta: il primo è un professionista che promuove il benessere e la salute ma che non può direttamente prendere in cura un paziente, il secondo, invece, ha il titolo per trattare patologie e disagi». Ma c’è molto di più, perché «fare divulgazione sui social è una forma di prevenzione: permette di avvicinarsi a chi non aveva mai pensato di intraprendere un percorso terapeutico». Già nel 2019, il quotidiano americano si chiedeva se gli Instagram therapist non fossero altro che i nuovi Instagram poet, “solo che invece di pubblicare versi usando l’American Typewriter (il font che replica lo stile della macchina da scrivere), condividono dichiarazioni sull’accettazione di sé e delle proprie imperfezioni, sull’importanza di prendersi cura di se stessi, sulla sindrome dell’impostore e, ovviamente, sui traumi”.
La domanda, provocatoria, mette ben in luce il vero dilemma della questione: essere uno psicologo attivo su Instagram è solo una moda, o nasconde qualcosa di più profondo?
Il rischio, si intuisce, è quello di imbattersi in qualche truffatore, qualcuno che si spaccia per esperto e che, invece, si limita a dare consigli pressapochisti o, peggio, a sparare diagnosi superficiali, influenzando chi in quel momento è alla ricerca di risposte. «Online si possono trovare curriculum o attestati che certifichino il titolo di un professionista. Senza contare che lo stesso Ordine degli Psicologi è consultabile liberamente», chiarisce la psicologa e psicoterapeuta Marzia Benvenuti (@cronachediunabionda, 55K). «Insomma, non è poi così difficile capire di chi potersi fidare davvero».
Il che ci porta a un altro punto: perché può capitare, ovviamente, che un follower, dopo essersi accostato a uno psicologo tramite Instagram, desideri diventare un suo paziente. «Certo, è inutile negarlo, questo è uno dei tanti vantaggi di fare divulgazione sui social. La notorietà fa aumentare i contatti», continua Benvenuti. «A me è capitato di ricevere richieste per colloqui individuali».
Ed ecco che i nodi vengono al pettine: non si rischia, in questo modo, di perdere di vista quel confine necessario che dovrebbe mantenersi tra paziente e psicologo? È possibile che avere accesso a così tante informazioni (anche private) riguardo ai terapeuti possa in qualche modo condizionare i pazienti, e viceversa? Come fa notare uno dei primi studi sul tema, condotto da Keren Lehavot, Jeffrey Barnett e David Powers (Psychotherapy, Professional Relationships, and Ethical Considerations in the MySpace Generation, 2010), in nessun’altra professione la questione della privacy del professionista è così importante quanto per chi lavora nell’ambito della salute mentale. Bisogna certamente prestare attenzione, tutelarsi, non mischiare i piani (specialmente considerando che non sono ancora state emanate delle norme specifiche da parte dell’Ordine degli psicologi). Anche perché, in realtà, la parte più rivoluzionaria e significativa dell’utilizzo dei social sembra essere proprio la possibilità, per gli psicologi, di mostrare un altro lato di sé.
«Permette di accorciare le distanze, di guardare all’essere umano che si nasconde dietro al titolo», spiega la dottoressa Benvenuti. Questo dovrebbe garantire un rapporto più sincero, empatico e diretto. Dovrebbe migliorare la qualità della relazione e, soprattutto, la consapevolezza che il proprio terapeuta non è un’entità distante, “un santone”, ma una persona come le altre. «Io non sono una psicologa, io faccio la psicologa. Non voglio essere ridotta a un ruolo. Capita spesso, e non solo su Instagram, che la gente si dimentichi di avere a che fare con un individuo in carne e ossa», aggiunge Capulli. «Penso che umanizzare il professionista sia propedeutico per costruire un ambiente protetto e non giudicante».
Di contro, ci si domanda se qualcuno possa credere che sia sufficiente limitarsi a scrollare post gratuiti, piuttosto che farsi seguire adeguatamente e privatamente. «Sì, alcune persone sperano di poter risolvere problemi invalidanti con ricette facili e standardizzate. È vero che la comunicazione divulgativa ha il senso di avvicinare la psicologia alle persone, ma Instagram non può in alcun modo sostituire un vero setting terapeutico». A rispondere è la psicologa e psicoterapeuta Cristina Di Loreto, founder and CEO di Brainheart e ideatrice del metodo Mefirst, un progetto di crescita personale interamente dedicato alle mamme. «Io lo specifico subito, nella bio del mio profilo: qui non faccio diagnosi. Il digitale fa parte della nostra vita e offre molte opportunità, ma è fondamentale sapere bene in che modo utilizzarlo, tenendo conto che non parliamo a un pubblico omologato. Non tutti hanno lo stesso grado di consapevolezza».
Ma tutto questo esporsi, tutta questa visibilità e notorietà, non finirà per nuocere alla categoria? «Dal mio punto di vista potenzialmente si può fare tutto», continua Di Loreto, «purché lo si faccia con professionalità. Sono le persone a fare la differenza: non bisogna fare promesse né creare illusioni». Certo, non mancano le critiche a questo tipo di approccio, soprattutto da parte di colleghi (e non solo). Ma, nella maggior parte dei casi, replica Benvenuti, sono solo bolle di sapone, che esplodono e si disintegrano nel nulla dopo essere state formulate (i classici attacchi dei “leoni da tastiera”, insomma). «È raro che un professionista si lanci in una diagnosi», conclude Capulli, «è necessario sempre essere cauti. Perché, di fatto, parlare sui social di questi argomenti è una grande responsabilità. Ma è una responsabilità che, tutto sommato, è molto stimolante poter avere».
Fonte: repubblica.it
Credit: foto di pexels-pixabay