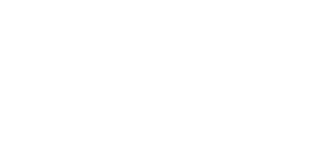Si chiama Mindstrong, è un’app, e sta facendo un gran parlare di sé. In buona parte perché tra i suoi ideatori figura Tom Insel, psichiatra a capo del National Institute of Mental Health per 13 anni, successivamente inglobato in Verily di Alphabet (ex Google Life Science). Non esattamente un signor nessuno ecco. Insel e i colleghi dietro a Mindstrong sono convinti che la loro app potrebbe rivoluzionare il trattamento delle malattie mentali e magari un giorno aiutare anche la diagnosi delle malattie mentali. Come? Sostanzialmente spiando le persone, in maniera continua, e radunando informazioni preziose sulle loro funzioni cognitive e sul loro umore, attraverso il monitoraggio e la registrazione di tutti i dati relativi a come digitano cifre e lettere sul telefono, se compiono errori, come scrollano pagine ed app, quanto si soffermano sui nomi della rubrica. Dati passivi, ribadiscono di Mindstrong (per inciso: non accessibile se non tramite codice, quindi non a tutti) nell’idea che questi svelino informazioni preziose sugli stati emotivi e sulla salute mentale della persona.
Quanto parla il nostro smartphone di noi?
L’idea di Insel e colleghi non è di certo nuova. Il filone del digital phenotyoping – l’ipotesi secondo cui la nostra vita digitale, tracciata più o meno attivamente, soprattutto attraverso wearable e smartphone, dica molto di noi, anche sul nostro stato emotivo e sulla nostra salute – è ormai quasi vecchia. Ma ancora perfettamente in salute, almeno a giudicare dalla produzione della letteratura in materia e dal fiorire di app, algoritmi o iniziative che mirano a tracciare profili o identificare comportamenti a rischio. O più in generale a dar senso a tutta la nostra vita digitale: cosa diciamo, più o meno coscientemente, quando parliamo, quando scriviamo, quando ci muoviamo, quando giocherelliamo con il nostro smartphone?
Nella proposta di Insel e colleghi il focus non è sui contenuti prodotti e utilizzati dagli utenti, quanto piuttosto nelle modalità con cui questi utilizzando i loro smartphone. In modo continuo e passivo. Non c’è infatti acquisizione di contenuto, ha ribadito di recente Intel in un’intervista alla Oliver Wyman – come invece cercano di fare altri team di ricerca, anche analizzando i post su Facebook – quanto di modalità di utilizzo, analizzata tramite tecniche di machine learning per guadagnare indizi preziosi su aspetti delle funzioni cognitive, dell’umore e degli stati emotivi. Nell’idea di Insel e colleghi questi dati, possibilmente e potenzialmente, sarebbero utili per comprendere e trattare anche i disturbi mentali.
La promessa del digital phenotyping
Una rivendicazione che a Mindstrong hanno cercato di supportare con i dati, ovvero monitorando l’utilizzo di alcune persone del loro smartphone da remoto e cercando delle correlazioni tra questo e le funzioni cognitive. Per farlo i ricercatori hanno sottoposto i partecipanti anche a delle valutazioni con test neuropsicologici classici. “C’erano segnali in quello che stavamo misurando che correlavano – predicevano, in realtà, non solo correlavano – con le misure delle funzioni neurocognitive raccolte dai neuropsicologi”, ha raccontato Paul Dagum, Ceo di Minfstrong, a Technology Review. Qualche esempio: i problemi di memoria (correlati ad alcuni disturbi mentali) erano associati alla velocità di digitazione e agli errori fatti digitando e ancora alla velocità di consultazione dei contatti.
È come se, in altre parole, avessimo a disposizione dei biomarker digitali da utilizzare, nella migliore delle ipotesi, come surrogato delle valutazioni neurobiologiche in laboratorio.
La promessa del digital phenotyping è grande, perché mira, trasformando lo smartphone in un sensore continuo, ad effettuare misure nella vita reale delle persone, al di fuori dei setting clinici: gli aspetti di una neomamma con depressione, ricorda Insel su World Pyschiaty, è diversa magari alle 3 del mattino rispetto all’esperienza che la mamma riferisce nello studio del medico il giorno dopo. Grazie al digital phenotyping potremmo in teoria avere accesso a informazioni almeno in parte nascoste, che sfuggono le maglie delle indagini tradizionali, senza partecipazione attiva da parte delle persone, nel loro ambiente naturale. Ma siamo già davvero in grado di dare senso e significato a tutto questo?
Serve, ancora, tanta ricerca sul tema
In realtà esiste più di qualche perplessità al riguardo: non la nasconde lo stesso Dagum che in un paper apparso di recente su Npj Digital Medicine ammette come servano ancora studi per confermare il potere predittivo dei digital biomarkers e perché questi possano diventare utili nella pratica clinica. Non a caso sono diverse le collaborazioni e le sperimentazioni portate avanti da Mindstrong con università e aziende farmaceutiche per mettere insieme questo tipo di dati. E per ripulirli da tutto il rumore, ovvero da tutti quei fattori confondenti che possano influenzarli, perché alcuni comportamenti possono ripercuotersi nel modo in cui usiamo il nostro telefono, come il non aver dormito, l’aver saltato le medicine, o l’aver bevuto un drink di troppo o anche solo aver le dita sporche, indossare i guanti. Problemi che da Mindstrong riconoscono di non aver ancora risolto.
Oltre alle difficoltà tecniche servono dati che provengano da ricerche indipendenti, che replichino quanto osservato e che dimostrino che effettivamente si possa utilizzare lo smartphone come un sensore. Ricerche che siano consultabili da altri, che siano confermate al di fuori della cerchia di Mindstrong. Serve – ancorché imperfetta – molta peer review sul tema della salute digitale mentale, ha ribadito Steven Steinhubl, direttore di digital medicine allo Scripps Research Translational Institute, a Stat News. E ancora di più ne serve per capire se possa o meno funzionare come un allarme antifumo, come un sistema in grado di segnalare ricadute nei pazienti con malattie mentali e allertare i clinici tramite la app. Magari portando a un adeguamento della terapia (e qui, ci ha ricordato un recente studio condotto dall’Oms, le cose non vanno affatto bene: riceve trattamento adeguato solo 1 paziente su 5 in caso di depressione nei paesi ad alto reddito, e 1/27 in quelli a più basso reddito).
Meglio un insieme di dati: oggettivi e individuali allo stesso tempo
Se tutto funzionasse, Mindstrong potrebbe trasformarsi in uno strumento utile anche in ambito diagnostico suggeriscono i loro ideatori, per scovare indizi di disagi e malattie prima che questi si manifestano. Più plausibilmente, commenta a Wired.it Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di Psiciatria e direttore del dipartimento di salute mentale dell’Asl Torino 3, l’idea di estrapolare indizi su stati emotivi e semmai disturbi mentali potrebbe diventare più concreta nel momento in cui vengano messe insieme diverse tipologie di dati. Non solo il modo in cui digitiamo o ci gingilliamo con lo smartphone: “L’uso di determinate parole, la velocità con cui vengono pronunciate, con cui si risponde, ma anche il tono stesso della voce, e ancora i dati relativi alla capacità di attenzione e concentrazione, ma anche le espressioni facciali combinati insieme possono raccontare molto. Di fatto – continua l’esperto – un sistema che connetta insieme tutti questi aspetti potrebbe monitorare la salute emotiva e psichica di un paziente, in maniera analoga a quanto fa oggi lo psichiatra combinando tutti questi aspetti in un esercizio di semiotica diretta”.
Un approccio simile, se nel prossimo futuro potrebbe funzionare come sistema di allarme appunto – segnalando quando ci sono comportamenti che richiedono attenzione e magari una visita di controllo – in futuro anteriore potrebbe essere particolarmente utile nel caso in cui non ci sia collaborazione da parte del paziente: “Quando una persona arriva, volontariamente da uno specialista, questo è già un segnale per lo psichiatra, che sa che la persona avverte un disagio e sta chiedendo aiuto. Diversamente accade per le persone che non collaborano, magari inviate per motivi legati alla giustizia: in questo caso infatti potrebbero essere messi in campo dei comportamenti di dissimulazione, per cui poter contare su un sistema che misuri tutti i fattori correlati al profilo comunicativo della persona potrebbero essere d’aiuto”. Purché, conclude lo specialista, si tratti di dati accurati e collaudati, che abbiano messo insieme dei pattern di comportamento in grado di identificare i profili delle persone a rischio di sviluppare per esempio depressione e attacchi di panico, ma non solo: “Fondamentale tener conto anche delle condizioni di base, ovvero del fattore individuale, per cui ogni persona parte da una condizione di ‘normalità’ diversa”.
Fonte: wired.it
Possiamo davvero usare lo smartphone per “leggere” la nostra salute mentale?