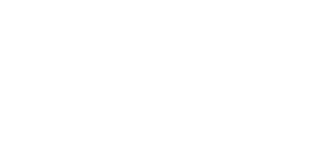tratto dall’Osservatore Romano – C’è un problema diffuso di interpretazione del disagio mentale e, a seguire, anche del senso del trattamento psichiatrico o psicoterapeutico. In nessun campo della medicina il concetto – già di per sé ambiguo – di salute è sfuggente come lo è in psichiatria. Forse è per questo che si sente la necessità di una demarcazione forte, come se l’idea stessa del disagio psichico possa in qualche modo contagiarci. Ciò che più ci protegge dalla «stranezza» dell’altro è sapere che in realtà, sotto sotto, non è veramente come noi. Possiamo così avvicinarci – anche moltissimo – ma è come se si rimanesse dall’altra parte di un vetro. Un po’ come allo zoo. Se la demarcazione si fa incerta, le cose invece si complicano moltissimo.
In realtà, il discorso vale anche a parti invertite, almeno per la sfera nevrotica. Chi non sta bene cerca spesso l’etichetta che lo definisca, che gli dia una patente di malattia, lo giustifichi rispetto alle proprie inadeguatezze e lo rassicuri sulla disponibilità direi «algoritmica» di una procedura terapeutica. Si mette, per dire, in una gabbia comoda (e ci sarebbe molto da riflettere su una società in cui bisogna sentirsi matti per sentirsi giustificati).
Rimanere invece in quella zona grigia, indefinita, in cui non conta tanto la malattia quanto la persona (le sue scelte, la sua libertà, il suo destino, la sua felicità), è terribilmente faticoso sia per chi sta al di qua sia per chi sta al di là di questa demarcazione artificiale.
E qui si manifesta il primo fraintendimento: per quanto la terapia possa prevedere colloqui, pillole, ricoveri e trattamenti più o meno coatti e per quanto l’indice della sua evoluzione sia rappresentato dai suoi sintomi, lo scopo reale dello psichiatra non è, come può sembrare, quello di curare la malattia.
Per chiarire, dobbiamo partire da un assunto fondamentale: al di là della sofferenza psichica, una qualunque forma di patologia psichica rappresenta una limitazione della libertà: la vera spia è quindi quest’ultima, la libertà del paziente, non la sua sofferenza. Estremizzo, per amor di chiarezza. È molto più facile di quanto si immagini combattere la sofferenza psichica: è quello che si faceva (e a volte ancora si fa) con la cosiddetta contenzione farmacologica. Non lego il paziente al letto (come nella contenzione fisica), ma gli do una dose talmente alta di farmaci che dal letto non può alzarsi. Obiettivamente quel paziente non soffre più, ma, appunto, non può alzarsi. Restituire a quel paziente la libertà è terribilmente più complicato. Può guidare la macchina? Uscire da solo? Vivere da solo, anche se sente le voci? Fumare due pacchetti di sigarette al giorno, anche se gli fa male?
Arriviamo così al secondo fraintendimento: la malattia e la capacità di autodeterminarsi non viaggiano necessariamente sulla stessa lunghezza d’onda. La libertà non dipende dalla gravità della malattia. Sempre estremizzando, un fobico che non può prendere l’aereo (un disturbo quindi clinicamente blando) non è libero come uno schizofrenico che su quell’aereo ci sale – e se è la prima volta magari anche gioiosamente. Se per quell’aereo il fobico rinuncia a un lavoro oltreoceano, la sua vita cambia enormemente, le sue possibilità si coartano. Allo stesso modo, un depresso che si toglie la vita non sta esercitando la propria libertà: al contrario l’ha persa completamente.
Non dobbiamo proteggere la sua vita come se fosse un bene astratto, separato, oggettuale: dobbiamo proteggere invece la sua libertà, attraverso la quale potrà riacquisire sempre più la titolarità della propria vita. Solo così potrà fare lui – e non noi – le scelte umane e responsabili che riguardano solo lui.
Come capiamo quali siano i limiti di questa libertà? Caso per caso, clinicamente. Curando non la malattia ma la persona. Cercando di cogliere e sviluppare le sue risorse senza pretendere di rimetterlo in pari rispetto a una ipotetica media o a un modello sociale. Aiutandolo a trovare il senso della sua storia, anche attraverso la sua sofferenza, anche quando dalla sofferenza non ci si riesce a liberare.
E qui veniamo a un’altra nota dolente: la sofferenza psichica del paziente può essere atroce, ma quella che noi non tolleriamo è troppo spesso la nostra sofferenza, non la sua.
È facile giustificare in questi casi scelte autolesive su una ipotesi dell’altro, su una sofferenza solo presunta perché non colta empaticamente: insomma, rimettendo il vetro.
Stare accanto alla domanda senza risposta immediata, al dolore senza strumenti pronti, è angosciante — e le angosce profonde scatenano movimenti inconsci potenti e altrettanto profondi: è più facile quindi ri-oggettualizzare l’altro e permettergli di spegnere quell’interruttore che ci tormenta facendoci sentire responsabili ma anche impotenti.
Terapia vuol dire invece prendersi cura, trattenere questa responsabilità, restituire all’altro la percezione irriducibile, sempre e comunque, che non sarà mai, in nessuna circostanza, materia di scarto. La terapia passa anche attraverso i farmaci ma la terapia, in psichiatria, è la relazione. Se si rinuncia a questa, si rinuncia alla vita del paziente.
La guarigione, qualunque cosa questa parola voglia dire, può non essere possibile: la cura non può mai essere impossibile.
Fonte: tempi.it