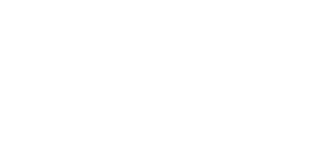Tutti conosciamo almeno una persona che ha sofferto di disturbi psichiatrici. Se così non è semplicemente non ci siamo accorti dei suoi problemi. In Italia ogni anno ci sono circa 4000 suicidi, metà sei quali, stando all’OMS, si sarebbero potuti evitare. È come se ogni dodici mesi un piccolo paese svanisse nel nulla.
La depressione, stando ai dati Istat, colpisce 2,8 milioni di persone mentre oltre 10 milioni, secondo una ricerca dell’Associazione Alpa, soffre di ansia e attacchi di panico. Negli Stati Uniti – che su alcuni temi sono una proiezione del nostro futuro – la situazione è ancora più grave: un adulto su due svilupperà una malattia mentale nel corso della sua vita, con 45 milioni di disturbi psichiatrici diagnosticati ogni anno. L’abuso di sostanze è epidemico e l’universo immateriale del “sempre connessi” maschera un profondo isolamento sociale.
La maggior parte dei casi di malattia mentale non viene curata, più che altro per una combinazione di stigma sociale e difficoltà di accesso alle cure. I più fortunati avranno in dotazione un terapeuta per renderli più compatibili con la società e un cocktail di farmaci per correggere gli squilibri chimici. Molti altri provvederanno a tamponare la situazione con le proprie forze, magari auto medicandosi con droghe e alcol.
In passato, quando di malattia mentale si parlava a malapena – oppure tutto veniva ricondotto alla teoria degli umori o alla frustrazione sessuale – il consumo di alcol era un buon lenitivo, soprattutto per le persone meno abbienti. Oggi non è cambiato molto, in realtà: l’associazione tra alcol e depressione è ampiamente documentata dall’OMS, e sembra destinata a crescere.
Palliativi a parte, un problema così radicato dovrebbe aprire a una riflessione: qual è la radice profonda? Lungi dall’essere un male contemplativo, un problema da ricchi annoiati e senza scopo o da intellettuali romantici con lo sguardo malinconico verso l’orizzonte, la depressione riguarda una percentuale massiccia di popolazione, che certo non coincide con le minoranze più agiate. Anzi. È possibile che di questa angoscia, di questo senso di solitudine e di miseria sia imbevuto il nostro stesso sistema sociale?
Oggi, dopo molti studi e dibattiti, sappiamo che alla radice dei disturbi mentali c’è una vulnerabilità genetica, attivata da circostanze ambientali e da eventi stressanti. Molti ignorano però che un qualche livello di vulnerabilità è riscontrabile nella maggior parte delle persone: per chi ce l’ha elevata, anche un evento minore può fungere da innesco; chi invece la possiede in basso grado ha bisogno di un trauma più significativo. In pratica, la vulnerabilità può essere tamponata dalle circostanze: quelle negative vengono definite fattori di rischio e quelle favorevoli, come una buona istruzione, l’accesso alle cure e relazioni sociali più positive sono fattori di protezione. Tra i più poveri, va da sé, i fattori di rischio sono maggiori e – come spiega la psichiatra Jeanne Miranda – i traumi sono così terribili e frequenti che “cercare tra di loro i depressi è come cercare i malati di enfisema tra i minatori di carbone”.
Il tasso di depressione tra i poveri è così alto che molti nemmeno si accorgono di essere depressi, né pensano di poter stare meglio. Nonostante quanto ne dica Vittorio Feltri, dunque, la depressione, è profondamente correlata allo stato economico. L’impoverimento porta a un peggioramento della salute, sia mentale che fisica. Le preoccupazioni finanziarie croniche causano distrazione e spossatezza. E ogni gradino sceso nella scala socio-economica comporta una regressione dello stato psico-fisico.
O meglio, la correlazione è
biunivoca, perché i disturbi mentali (o un corpo malato) portano spesso a un
impiego peggiore e un reddito ridotto, finendo per consolidare una situazione
di povertà che a sua volta aumenta il rischio di disturbi mentali. La
povertà è deprimente e la depressione impoverisce.
Alcune ragioni di questo rapporto interdipendente sono abbastanza ovvie:
l’accesso alle cure è più difficile, la dieta è meno sana, nei casi estremi,
come chi vive per strada, le condizioni igieniche e l’isolamento non possono
che essere malsane. Ma ci sono anche fattori più subdoli. E per capirli
dobbiamo tenere presente il fatto che la nostra biologia è in continuo
mutamento: i fattori positivi e negativi che si accumulano durante la nostra
vita influenzano i nostri caratteri epigenetici, psicologici e comportamentali.
Per esempio, lo sapevate che il volume dell’ippocampo è inferiore di un
buon 5% nelle donne che da bambine hanno subito abusi sessuali?
Lo stress è un fattore di modifica davvero enorme. In particolare, secondo il professore Robert M. Sapolsky della Stanford University, un fattore di stress decisivo sono proprio le conseguenze psicosociali causate da un basso livello socioeconomico. Lo stress è attivato soprattutto da come le persone percepiscono il proprio benessere rispetto a quello degli altri: in pratica, più ci si sente poveri, più la propria salute ne risente. Non a caso la depressione è largamente più diffusa nelle società che hanno un più alto indice di disuguaglianza. È la teoria già nota della deprivazione relativa e Sapolsky è riuscito a dimostrarla con una ricerca sui babbuini che vivono in libertà nell’Africa orientale. I suoi studi hanno mostrato infatti che i babbuini di “ceto inferiore” riscontrano anomalie nella secrezione di ormoni dello stress come il cortisolo, più altre conseguenze negative sul sistema immunitario, cardiovascolare e sessuale.
Anche negli essere umani – come nei macachi rhesus studiati dalla biologa Jenny Tung – i livelli elevati di stress continuativo possono portare all’infiammazione cronica, con conseguenti danni molecolari in tutto il corpo. Inoltre, fattori come depressione maggiore, disturbo da stress post-traumatico e discriminazione razziale possono accelerare l’accorciamento dei telomeri, cioè rendere più rapido l’invecchiamento.
Non solo, l’impoverimento modifica anche cervello e comportamento. Come spiega ancora Sapolsky, lo stress prolungato ha effetti negativi sull’ippocampo, che presiede all’apprendimento e alla memoria; sull’amigdala, con un aumento delle reazioni di paura e ansia; sul sistema dopaminergico mesolimbico, e quindi sui sistemi di ricompensa, aspettativa e motivazione; e anche sulla corteccia prefrontale, indispensabile per la pianificazione a lungo termine. Il che la dice lunga sul fatto che i più indigenti sono meno portati a perseverare con le cure, al di là dei risultati immediati. “La povertà – spiega Sapolsky – fa sì che il futuro sembri meno rilevante”, e a pensarci bene non è che un razionalissimo sistema di autodifesa.
Un sistema che, naturalmente, ha gravi effetti collaterali. Come spiega per esempio Glenn Treisman della Johns Hopkins, che ha studiato la depressione tra le popolazioni indigenti e siero positive di Baltimora, “Molte persone contraggono l’HIV quando non riescono a radunare sufficiente energia per preoccuparsi e quindi per essere prudenti”. Le persone povere e depresse, conferma Treisman, in genere si sentono così impotenti da non cercare nemmeno aiuto. Si sentono disarmate di fronte al destino, ed è una sensazione umiliante.
Nonostante tutti questi studi – o quelli della Gulbenkian Mental Health Platform in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO) che hanno prodotto la ricerca I determinanti sociali della salute mentale – nella mentalità corrente la variabile sociale della malattia mentale tende ad essere accantonata, quando non ridicolizzata. Secondo Mark Fisher nel suo Realismo capitalista: “la chimico-biologizzazione dei disturbi mentali è strettamente proporzionale alla loro depoliticizzazione”. È chiaro: che se il problema è genetico, quando la colpa non ricade sul malato stesso, la responsabilità si limita alla sorte crudele, mentre il sistema economico e il nostro assetto sociale ne escono immacolati. In pratica, “sei malato per colpa della chimica del tuo cervello”. È un discorso confortante, perché chi è sano pensa che lo sarà per sempre, ed è piacevolmente deresponsabilizzante, perché la questione riguarda solo il malato, i suoi eventuali medici e l’Onnipotente. Vogliamo credere che, se riusciamo a reggere lo stress, è per la nostra grande tempra e la nostra forza di volontà, e non perché ci sono nella nostra vita circostanze che lo tamponano. Mentre chi non riesce è un individuo debole dal punto di vista fisiologico, o semplicemente pigro.
Ma guardiamoci intorno: i salari sono stagnanti o in calo per la maggior parte delle famiglie, molti (soprattutto i giovani) vivono in una condizione di permanente instabilità e chi ha la fortuna di avere un impiego stabile lavora più ore rispetto a un contadino medievale. Gli spazi pubblici sono pochi e sempre più privatizzati: i luoghi in cui sia possibile socializzare senza spendere, infatti, sono sempre meno.
Molte delle nostre professioni, inoltre, sono più che mai caratterizzate da quella che Marx, riferendosi alla Rivoluzione industriale, chiamava “teoria dell’alienazione”. Molti lavoratori sono cioè privati della soddisfazione di produrre qualcosa che si vede e di cui essere orgogliosi. Se il proprio lavoro – dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo da svegli – è percepito come senza significato, la salute psichica non può che risentirne. Eppure non dare priorità al lavoro è impensabile, non solo perché dà da mangiare, ma perché la nostra autostima è interamente misurata dalla nostra produzione economica. Mentre la nostra immagine pubblica, veicolata dai social, è modellata – consapevolmente o meno – intorno a principi aziendali e su paragoni sempre più costanti. Come possiamo pensare che tutti questi fattori non influiscano sulla nostra salute mentale?
Non solo, il capitalismo contemporaneo è promotore e incarnazione di un’ideologia molto estrema, l’individualismo, che vede il motore vitale nel profitto personale e nella competizione, escludendo l’aspetto cooperativo. Ed essendoci, formalmente, un’uguaglianza di opportunità (la solita, ma sempre sottovalutata dicotomia tra uguaglianza di diritto e uguaglianza effettiva) per qualunque sconfitta, per qualunque disagio, per qualsiasi ritardo o svantaggio, in questo conflitto globale permanente l’unica persona da incolpare resta sé stessi, con il risultato che l’ansia da prestazione addirittura precede la sconfitta, e a volta la determina.
I molti studi sull’infanzia dimostrano come la competizione estrema, intesa come paura di non emergere, terrore della mediocrità e peso del giudizio altrui, si formi già prestissimo. Mostrano anche come la componente genetica sia radicalmente surclassata da quella ambientale. Le patologie come depressione e nevrosi, infatti, sono ereditarie solo per il 30%, mentre i bambini adottati provenienti da un contesto disagiato, una volta approdati in una situazione più confortevole e meno emergenziale, sono in grado di recuperare moltissimi gap. Per tutti gli altri lo svantaggio comincia prima della nascita e si accumula sempre di più lungo il corso della vita. Ma un approccio che prenda in considerazione l’impatto dei determinanti sociali potrebbe fare molto per tamponare i fattori di rischio e ridurre lo svantaggio, anziché amplificarlo.
È importante intraprendere azioni per migliorare le condizioni di vita quotidiane, iniziando dal momento della nascita. L’importanza delle primissime esperienze per determinare ciò che diventeremo dovrebbero essere un imperativo per creare società in cui i genitori abbiano sempre più possibilità di andare incontro alle esigenze dei figli. Un altro aspetto su cui lavorare è la coesione sociale. Uno dei motivi per cui il fascismo è in aumento in Occidente è perché è in grado di dare un senso, uno scopo e un’idea di collettività, per quanto imbastita sull’emarginazione e sull’odio per l’altro.
L’errore principale è considerare i problemi di salute mentale come qualcosa di naturale e ineluttabile, e quindi da scaricare totalmente sull’individuo, con una privatizzazione dello stress che non fa che aumentare lo stigma e l’isolamento. Qualsiasi campagna sulla salute mentale è inutile se non promuove la lotta alla povertà e, soprattutto, alle diseguaglianze: quel che serve è assumersi la responsabilità sociale di evitare l’evitabile.
Fonte: linkiesta.it
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/04/18/borghesia-depressione-poverta-capitalismo/41802/